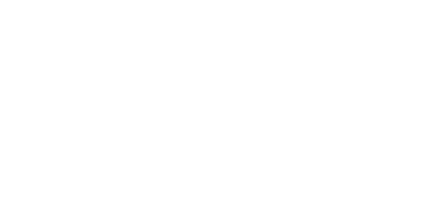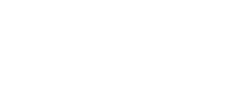Bellezza e rappresentazione delle donne nell’Italia fascista

a cura di Margherita Becchetti o Michela Cerocchi

Poiché la distinzione chiara e netta dei ruoli di genere fu un punto centrale dell’ideologia fascista, negli anni del regime mussoliniano si alternarono frequenti battaglie culturali sulla questione della bellezza femminile e della moda. Molti pubblicisti e intellettuali si interessarono dell’aspetto delle donne, esprimendo vivacemente cosa fosse, secondo il loro punto di vista, accettabile e cosa no. Questo perché la discussione sulla bellezza implicava in realtà questioni ben più profonde, che avevano a che fare con il ruolo della donna nella società e con la necessità, per la cultura maschilista del regime, di soffocarne le spinte emancipatorie che in quegli anni animavano gran parte del mondo femminile occidentale. Gli anni successivi alla Grande guerra, infatti, furono un’epoca di cambiamento anche sul piano della vita quotidiana di milioni di donne. Parallelamente al moltiplicarsi, nei diversi paesi, delle richieste di voto femminile, l’evoluzione della stampa e della pubblicità mise in circolazione anche in Italia un’idea moderna della femminilità urbana, nella quale l’attenzione alla moda, l’uso dei cosmetici, il divertimento e lo sport indicavano non solo il sorgere di nuovi ideali di bellezza, ma anche – e chiaramente – la differenza generazionale e di genere.
I modelli femminili veicolati dai nuovi mezzi di comunicazione – cinema in primis con le biondissime star hollywoodiane Greta Garbo, Jean Harlow e Joan Crawford – erano emulati anche dalle donne italiane, soprattutto quelle che popolavano le città del nord – commesse, segretarie, studentesse, dattilografe – che costituirono l’avanguardia di un processo di modernizzazione dei ruoli femminili che finì per influenzare non solo l’aspetto esteriore delle donne ma anche comportamenti e aspirazioni più sostanziali, tesi ad un’indipendenza in conflitto con il tradizionale confinamento femminile nella sfera domestica. Le immagini di donne attraenti – come le donne alla moda di Marcello Dudovich o la «signorina Grandi firme» di Gino Boccasile – erano in netto ed esplicito contrasto con le preferenze tradizionaliste del fascismo e della cultura cattolica dominante nella società italiana e furono fonte di conflitto nella battaglia di retroguardia combattuta dal fascismo contro gli ideali di bellezza importati dall’estero.
Le ragazze giovani, lavoratrici, che portavano i capelli corti, utilizzavano cosmetici, fumavano, disdegnavano le convenzioni e, abbandonati busti e corsetti, vestivano alla moda pratica degli stilisti francesi Chanel e Poiret, in Italia scatenarono ondate di panico morale. Esse, infatti, mostravano in modo evidente quanto la famiglia, la Chiesa e le convenzioni sociali non fossero più le uniche forze in grado di condizionare il modo in cui le donne si presentavano al mondo esterno e che un richiamo seducente proveniva ormai anche dai mass media e dalla società dei consumi che si profilava all’orizzonte.
La bellezza tradizionale italiana evocata continuamente dal regime, dalla sua propaganda e dai suoi intellettuali, assurse dunque in quegli anni a valore da conservare e difendere rispetto alla modernità aliena, vessillo da sbandierare nella battaglia contro i cambiamenti indesiderati, dimostrando così quanto essa fosse non solo il frutto delle politiche autoritarie alla base della campagna fascista di incremento demografico ma anche dell’ostilità maschile all’emancipazione della donna moderna.